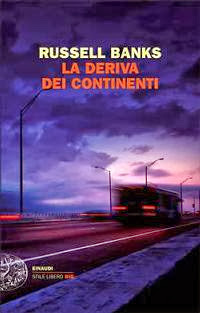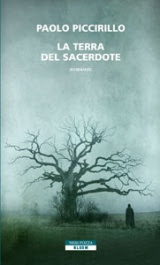E’ un romanzo indefinibile, “Bambini bonsai”.
Se provassi a raccontare la trama, potrebbe sembrare un libro per criaturelli.
Ma non è un libro per bambini, è un libro sui bambini, è un libro sulla presa di coscienza che “l’infanzia finisce, e che una bambina bonsai non la si può sradicare.”
Sono le ultime parole del libro.
La bambina bonsai è Sofia.
Sofia ha occhi come gialli e polposi come albicocche, e il suo viso è riprodotto su ogni cosa: scatole, figurine, poster.
Sofia è come la principessa addormentata da un malefico sortilegio, e un piccolo scudiero coraggioso e innamorato la sveglierà dal suo sonno, la porterà via dal castello, ad affrontare la vita, anzi, la morte.
Detto così sembra una fiaba, ma della fiaba il romanzo di Zanotti ha solo la ricchezza delle invenzioni, le magie e la valigia di Petronilla, la capo-banda, il deus ex machina dell’inganno e dello svelamento.
Ma non è una fiaba, lo scenario sembra quello di un romanzo distopico apocalittico fantascientifico: è ambientato in una Genova franata e compressa, in un tempo forse non troppo remoto dove tutti gli animali sono scomparsi, dove tutte le isole del Pacifico sono sommerse da un mare che sembra un mostro di plastica e munnezza, e dove ai padri, se vittime di incidenti, si sostituiscono i pezzi mancanti con protesi meccaniche; dove il sole brucia e fonde, tant’è che solo nelle serre si potrà vivere, dopo l’ultima pioggia, quella che porta anche il gelo e il freddo, quando anche l’ultimo grande agglomerato della città, il cimitero di Staglieno, affollato di case arroccate tra le tombe, lapidi, guglie e statue, verrà abbattuto.
Ma non è neppure un romanzo distopico fantascientifico nel senso stretto, perché i protagonisti sono bambini che approfittano della pioggia, un evento terribile e mostruoso per compiere il rito di passaggio dall’infanzia (la prima vissuta quasi tutta in un secchio) all’adolescenza e poi all’età del disincanto, all’età adulta, approfittando del “letargo” , del sonno degli adulti.
Dice Pepe, il protagonista che racconta del suo tempo della pioggia:
“E allora mi chiedo (…) se anche di fronte alle piogge violente, alle piogge vere, la reazione degli adulti non fosse dettata solo dall’istinto, da un’incapacità naturale di venire a patti con la pioggia, ma anche da qualcosa di più ambivalente, un groppo di emozioni che comprendeva la paura del sovvertimento dei giorni, il lutto per le terre erose e sommerse, la nostalgia di quando si erano sentiti vivi. In fondo, dice qualcuno, la paura non è che la sorella cattiva della nostalgia.”
I bambini approfittano della “vacanza” dei grandi, riunendosi in bande, per fiondarsi in un mondo alieno e spaventoso - una grande avventura - dove tutto si può fare: occupare le stazioni e giocare a fare i mercanti, rintanarsi in una galleria per fare grandi sfide con le automobili, incontrare il mare, grande mostro morente.
E’ forse un romanzo di formazione, scritto in un modo assolutamente originale, ma è soprattutto un romanzo sul potere straordinario dell’immaginazione che è propria di una certa età, quando tutto è possibile: parlare ed essere amici delle statue e di animali estinti, evocare greggi di pecore e animaletti sui bordi dei secchi; di un tempo in cui anche la paura è attraente, e si possono affrontare le ire della natura foderando le scarpe con il cartone; doti a cui, costretti nella gabbia dell’adultità, dobbiamo rinunciare per seguire sogni e segni più concreti.
“E’ stata quella la mia prima perdita. Bambino cresciuto nell’agglomerato senza varcarne mai i cancelli, fino a quel momento mi ero illuso che crescere significasse solo accumulare cose nuove. Ma ecco che dovevo aprire gli occhi. Prendere atto che a ogni nuova tappa occorre rinunciare ai privilegi di quella precedente.”
E’ un romanzo sulla nostalgia di un tempo che non ritorna e che non si può bloccare, così come non ritornano le nuvole vere nel cielo di serra di Pepe adulto.